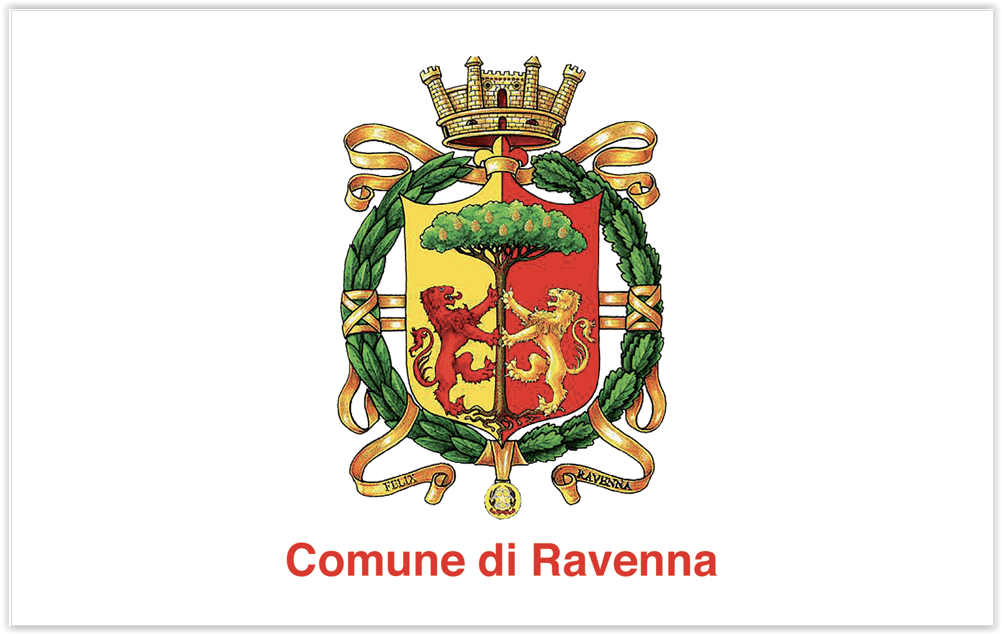Festival delle culture 2022. XV edizione
Giugno 2022
Il Festival delle Culture, se lo vivi fino in fondo, ti lascia sempre un po' di nostalgia.
C'è un'aura di magia che lo avvolge, una specie di recinto invisibile, che assomiglia un po' a un abbraccio, che ti dà una sensazione di stare, per qualche giorno, in un mondo giusto.
C'è una canzone di Brunori Sas, che parla evidentemente anche di migrazioni, si intitola Al di là dell'amore. Mi è tornata alla mente mentre il Festival iniziava, si dipanava e, come ogni anno, finiva. E mi sembrava, ancora una volta, che stesse tracciando «il confine fra il bene ed il male».
Il Festival è anche una specie di sussulto.
Per se stessi, prima di tutto. Perché è impossibile uscirne senza sentire, forte, il bisogno di andare a curiosare ancora. A me, per esempio, è venuta una gran voglia di leggere tutti i libri di Asmae Dachan, giornalista italo-siriana, che nel parlare di guerre dimenticate ha tirato fuori non solo la Siria, Paese disastrato, ma anche l'Etiopia, questa sconosciuta. E poi vorrò trovare il tempo di leggere i racconti e i romanzi che ancora mi mancano di Etgar Keret, che ho avuto l'onore di presentare durante la prima serata, protagonista insieme a Ece Temelkuran, ma che non smette mai di stupire per freschezza, ironia e genialità, mentre parla e mentre scrive. Con Federica Ceccoli, l'interprete che ha tradotto le mie domande e ha restituito al pubblico le risposte, siamo andati a bere qualcosa alla Darsena Pop Up, dopo l'incontro, e sia Keret che Temelkuran si sono rivelati quello che già erano sembrati sul palco: persone alla mano, umili, che hanno uno sguardo e una scrittura di talento e sanno parlare di tutto ma non smettono di essere amichevoli e cordiali, forse perché non hanno davvero bisogno di tirarsela. Per loro, vale quel che scrivono.
Il Festival ti induce, necessariamente, a farti delle domande.
A chiederti che cosa fai tu, nel tuo piccolo, per renderlo un po' migliore, questo mondaccio. Se combatti anche tu una battaglia contro ciò che non funziona e se prendi una posizione, semplicemente facendo e non solo parlando. E mi ronza in testa di nuovo Brunori in Secondo me, quando canta che sì, parliamo sempre di immigrati ma «in un campo rifugiati a noi non ci hanno visto mai». Le domande arrivano anche di colpo, mandano in mille pezzi lo specchio in cui ci riflettiamo, il più delle volte egocentrici e narcisi.
Al Festival la dirompenza più forte, nel rompere lo specchio, è stata senza dubbio quella di Nawal Soufi, sorriso grande e capelli neri, lei che attraversa le foreste dei Balcani con i migranti, per andare a testimoniare che cosa accade in frontiera e metterci la faccia, le mani e le unghie quando c'è da difendere i diritti umani di chi scappa dal proprio Paese e insegue un sogno. Nawal Soufi, l'angelo dei profughi come l'hanno definita nel titolo del libro che narra di lei, è un gigante. Parla a macchinetta perché ha il cuore pieno di occhi, di bocche, di mani. Perché «quando alla frontiera tra la Polonia e la Russia una mamma ti chiede di andare a vedere se suo figlio è morto, significa che quella donna è già morta dentro». E lei lo sa.
Il Festival è anche la conferma che a volte esiste un riscatto, che non è tutto piano, che non è tutto uguale a prima, uguale a sempre.
Un riscatto di gente di cui non sappiamo, in genere, nulla. Quello di Joshua Ojomon, voce e tastiere per l'Orchestra dei Braccianti, che sul palco dell'Almagià non era più un raccoglitore di meloni a pochi euro l'ora ma un musicista vero, che il ghetto e il caporalato se li è lasciati alle spalle. Mentre cantava «Redemption song», però, era universale. Parlava di lui, parlava di lei, parlava di loro, parlava di noi. Di noi che pensiamo che il popolo afghano sia un contenitore da riempire, una massa passiva.
E invece, ci ha insegnato il giornalista Giuliano Battiston, ci sbagliamo proprio. Così come ci sbagliamo a descrivere le altre culture con il solito occhio orientalista, che le sminuisce e le mortifica. Ce lo ha segnalato Leila Belhadj Mohamed, podcaster, che a gamba tesa combatte la narrazione comune sull'immigrazione. E Stefano Massini, magistrale nel suo monologo sul lavoro, che nel meravigliare il pubblico con le sue storie, ci ha fatto sentire per venti minuti tutti sulla stessa barca. Perché sì, il crollo del Rana Plaza, avvenuto nel 2013 a Dacca, sembra lontano anni luce e troppi chilometri. Ma la morte di Luana D'Orazio in una fabbrica tessile di Prato pare molto più vicina. Ma Luana potrebbe essere la stessa donna bengalese che quel giorno riempì con il chewing-gum la crepa che aveva visto sopra la sua testa, mentre iniziava a lavorare, per capire se il giorno dopo sarebbe stata più lunga. E nonostante le segnalazioni, si vide crollare un intero edificio di otto piani addosso, insieme a migliaia di persone come lei, che andavano a lavorare per vivere, ma ci sarebbero poi morti sotto.










Il Festival, mentre ti scombussola dentro, è anche incredibilmente leggero.
Forse perché è una festa, in fin dei conti. Forse perché è di tutti. Forse perché anche quando si denuncia un'ingiustizia, si può ridere, ce lo ha mostrato Etgar Keret, chi meglio di lui che ogni notte, in Israele, rischia di svegliarsi perché suona un allarme missilistico o c’è un’esplosione.
Il Festival è leggero perché si mangia, perché si balla.
Si balla sulle note di musiche che non abbiamo forse mai ascoltato prima, ci si lascia trascinare da ritmi magrebini, balcanici, haitiani, come è successo quest’anno E ci si diverte a inventare di saper danzare, a lasciarsi andare, a sperimentare che siamo tutti sotto un palco, grandi e piccoli, italiani o chissà da dove, ma cosa importa, in fin dei conti.
Bastava partecipare alla parata inaugurale, anche solo andarla a vedere, per cogliere l’atmosfera del Festival. Le bandiere cucite insieme, i tamburi, il centro invaso da quel corteo di colori.
Mentre camminavamo come un fiume in piena verso la Darsena, mi ha fermata una turista di lingua spagnola: «Señorita, qué maravilla! Qué celebráis hoy?». La meraviglia, appunto.